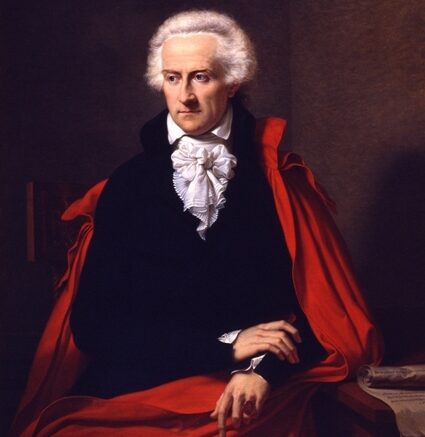1.La vita.
Nasce ad Asti il 17 gennaio 1749. Tra il 1758 e il 1766 viene mandato a studiare alla Reale Accademia di Torino. Vi riceve una educazione militare rigida e superficiale. In quanto nobile, intraprende una serie di viaggi in Italia e in Europa. In italiano la sua prima tragedia, Antonio e Cleopatra. Si impegna nella scrittura di tragedie, rinnegando il passato di godimenti e ozio. Studia i classici italiani e latini e cerca in Toscana la propria patria ideale. Stringe amicizia col nobile Francesco Gori Gandellini. Si lega sentimentalmente a Luisa Stolberg-Gedern, contessa d’Albany e moglie di Carlo Edoardo Stuart, aspirante cattolico al trono inglese. Dona i propri possedimenti piemontesi alla sorella Giulia, in cambio di un cospicuo vitalizio. A Roma mette in scena l’Antigone e scrive il Saul. A Milano conosce Parini. Escono a Siena i primi due volumi delle Tragedie. Dopo spostamenti in Francia e Inghilterra, si ricongiunge con la sua donna in Alsazia. A Parigi incontra Goldoni. Edita diverse opere, tra cui le Rime e la Vita. Nel dialogo Della virtù sconosciuta, pubblicato nel 1788, celebra la figura dell’amico Gori Gandellini morto nel 1784. Celebra la Rivoluzione francese componendo l’ode A Parigi sbastigliato. Tuttavia, nel tempo, al crescere della violenza politica, diventa critico verso la rivoluzione, fino a odiare i francesi. Muore l’8 ottobre 1803. Negli ultimi anni s’era dedicato alla stesura delle Commedie e del Misogallo. Il mito di Alfieri padre della patria viene fissato pochi anni dopo nei Sepolcri di Foscolo.
2.Le tragedie.
La sua è una tragedia di carattere tutta costruita tutta intorno alla personalità del protagonista o di pochissimi personaggi. Cerca uno stile proprio. Sulla scia della famosa Merope di Scipione Maffei si svolge all’uso dell’endecasillabo sciolto. La prima tragedia che egli riconosce è il Filippo. Abbiamo poi: Polinice (ispirato alla Tebaide di Stazio). L’Antigone è la prima tragedia scritta in italiano in ogni sua fase. Abbiamo poi: l’Agamennone, l’Oreste. Legate al trattato Della tirannide sono le opere Virginia, la Congiura de’ Pazzi, il Timoleone. Abbiamo poi: Don Garzia; Rosmunda; Ottavia. Il Saul è uno dei capolavori di Alfieri: il re Saul, invidioso di David, sposo della figlia Micol, si ribella alla volontà divina che lo vuole suo successore e lo scaccia, incontrando così la rovina. In Saul Alfieri trova il personaggio ideale per esprimere il proprio ambivalente atteggiamento nei confronti del conflitto tra potere e libertà.
Altre tragedie: Mirra (solitudine conseguenza dell’amore). Agida e Sofonisba sono invece un sostanziale fallimento. Ancora: Bruto primo; Bruto secondo. Per l’Abele Alfieri conia il termine “tramelogedia”, un genere intermedio tra la tragedia e il melodramma. Ancora: Alceste seconda.
3.Le Rime e la Vita.
Le Rime escono nel 1789: modelli barocchi, arcadici, Dante della Vita nova, Petrarca. Vena autobiografica espressa in Vita di Vittorio Alfieri scritta da lui stesso. È considerata l’opera più vitale di Alfieri.
4.Gli scritti politico-morali e la produzione satirica.
Della tirannide (1777, stampato nel 1789), teorizza l’inconciliabilità dell’uomo libero con il potere assoluto. Poemetto in 4 canti in ottave è L’Etruria vendicata. Del principe e delle lettere, diviso in tre libri (1778-1786), esamina la contrapposizione inconciliabile tra potere politico e letteratura. Condanna anche il mecenatismo. Panegirico di Plinio a Traiano, tema politico. Satire: I re, I Grandi, La Milizia, L’Educazione, La Plebe, La Sesquiplebe (il ceto medio), La Filantropineria, L’Antireligioneria, Le Imposture, Il Commercio.
Commedie: L’uno, I pochi, I troppi, L’antidoto (ßtetralogia). La Finestrina, il Divorzio.
5.La fortuna.
Parini e Monti non lo apprezzano. Foscolo lo elegge guida morale. Nell’Ottocento è stroncato dal drammaturgo e saggista Schlegel. Cesare Cantù lo giudica astratto. Paolo Emiliani Giudici lo esalta ideologicamente accostandolo a Eschilo. Luigi Settembrini lo esalta come pure Francesco De Sanctis. Benedetto Croce lo definisce protoromantico. Mario Fubini pone l’accento sul pessimismo di Alfieri. In lui si riconosce il carattere apolitico e metastorico della sua tragedia e della critica alla tirannide.